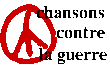Si fa un talkin'?
Si fa un talkin'.
Partimmo una mattina verso Salonicco, io, la mia ragazza ed una Fiat Ritmo che reggeva l'anima coi denti, ma che era munita di un'autoradio. Vestiti leggeri, perché era il 21 luglio. Del 1990. Da Dubrovnik, che è una città bellissima. Da Dubrovnik che, l'anno dopo, sarebbe stata bombardata. Buchi nei tetti delle chiese. I palazzi dello "Stradun", i palazzi di pietra rosata in preda alle fiamme. I sacchetti di sabbia sotto la Fontana di Sant'Onofrio.
Era un periodo in cui la mia ragazza non amava troppo Guccini; ma da Dubrovnik a Salonicco ci sono novecentoundici chilometri di strade di merda. Prima di partire guardavo la cartina preoccupato; tutto il Montenegro, tutto il Kosovo, tutta la Macedonia e poi il confine con la Grecia, in un posto chiamato Gevgelija. Guai a chi m'avesse fatto traversare tutti i Balcani senza un po' di Guccini.
C'eravamo stati due anni prima, in Jugoslavia. In ogni posto, anche nei cessi, c'erano ritratti del Maresciallo Tito. Anche nei paesi più piccoli c'era una via che si chiamava "Ulica Bratstva i Jedinstva", via della Fratellanza e dell'Unità. Un po' come "via Roma" in Italia. Fratellanza e Unità. Già. Anche l'autostrada Zagabria-Belgrado si chiamava "Autoput Bratstva i Jedinstva". Ecco. Due anni dopo in Croazia c'erano ovunque le bandiere a scacchi bianchi e rossi. La signora Lijepe (vuol dire "Bella"), la nostra padrona di casa a Dubrovnik, si lamentava ogni mattina che era troppo "vruce", troppo caldo. Leggeva "Slobodna Dalmacija" bestemmiando contro i nazionalisti, diceva d'essere una vecchia comunista e una volta le ho rovesciato la vasca da bagno mettendomi a sedere sul bordo.
Un'ultima occhiata a Dubrovnik, dall'alto. Dopo dieci chilometri sei già a quasi mille metri d'altitudine. Il mare che scompare. Scompare l'Adriatico, scompaiono le delicatissime architetture veneziane, le "vere da pozzo", le lunghe scalinate fra gli oleandri. Di posti ne ho visti tanti, ma mai ho visto un confine tra due mondi in pochi chilometri d'una stradaccia.
S'arriva a Trebinje, che è in Erzegovina. Un'immensa caserma. Un'aria livida, strana, soffocante. Un soldato altissimo, biondissimo che vede una macchina con targa italiana, la ferma e mi chiede una sigaretta in inglese. Gli rispondo in serbocroato e si mette a ridere, perché è della Vojvodina, dove parlano quasi tutti ungherese. E allora gli do un pacchetto di Chesterfield, e lo saluto in ungherese.
"Viszontlatásra barátom". Arrivederci, amico. Mi guarda e se ne va; chissà che fine ha fatto. Da Trebinje hanno rovesciato tonnellate di bombe su Dubrovnik, come prendere qualcuno a sassate da un albero.
La mia ragazza non parla quasi mai. Guarda; si sale ancora, cominciano le abetaie. M'accorgo che sto per infilare la cassetta dove c'è "Canzone per un'amica", ma quella canzone, per strada, forse non è il caso di sentirla. Accendo la radio; un notiziario, musica strana, un caldo soffocante. Alla fine, vaffanculo. Quella non parla e guarda, non ci sono che alberi e l'aria si fa rossastra. Quando arrivo a Canzone per un'Amica, la salto. Anzi no, la sento. La strada era lunga, ma non correva affatto ed era piena di tornanti.
Gole. Gole profondissime. Non c'è un cazzo di nessuno. La mia ragazza, lo vedo, è leggermente terrorizzata; mi dice che sono un idiota, che son voluto passare di lì quando potevamo prendere una nave e ritrovarci a Patrasso. Aveva ragione. Le dico se vuole che torniamo indietro; ma si richiude nel suo mutismo. Ed allora vado avanti.
Avanti, avanti, fra le tombe dei Bogomili dell'Erzegovina, fra le tombe dei terribili bulgari che avevano seminato il terrore in mezz'Europa, mille anni prima. Fino a casa mia sono arrivati; il nome di Bòlgheri, il paese della poesia del Carducci, quello dei cipressi alti e schietti in duplice filàr, deriva da "bulgari". Glielo dico, ma non gliene frega niente. Merdre à toi, bogòmilo di merda. Lo dice Salvatore al cuciniere nel "Nome della Rosa". E si sale, si sale.
Comincia a fare meno caldo; poi fresco; poi decisamente freddo. C'è nebbia; lei s'è messa un asciugamano di spugna addosso, non avevamo altro e vattelappesca. Un vecchio gigantesco con una zappa sulla spalla, gli domando quanto manca a Titograd. Dva ciàsa. Ciàsa, ciàsa...già, qui parlano mezzo turco. Ciàsa vuol dire "ore" in turco. Due ore. Il vecchio scompare nella nebbia, in una stradina laterale.
E s'arriva a Titograd, città di Tito già dedicatagli in vita, come se Pàvana già adesso la chiamassero Guccinigrad (in treppiese, che, come disse un decerebrato qualche tempo fa, ha delle assonanze con il macedone). Ora ha ripreso il vecchio nome di Podgorica, che vuol dire "sotto i monti" e si pronuncia "podgòrizza". E ci credo. Monti e abeti, castagni e monti, monti e bambini per la strada. Carovane. La fanciulla ha un sussulto; "qui si muovono tutti". "Sembra che scappino", le rispondo. Già.
Altri monti, e una discesa a perdifiato. I cartelli stradali cominciano ad essere bilingui, in serbo e in albanese. "Eccoti la lingua dei tuoi avi", le faccio. Sono un monomaniaco; lingue e Guccini. La fanciulla fa Albanese, di cognome; siamo nel Kosovo. Nel Kosovo Polje, il "campo dei merli" dove, nel 1389, i serbi erano stati sconfitti dai turchi, dove esistono ancora dei vecchi "guslari" che ti cantano le antiche ballate per pochi spiccioli, una melanzana o un pezzetto di carne, dove vendono acqua e limone per la strada. Baracche e trattori; sul muro scritte, scritte e scritte. Quelle in albanese non le capisco; ma ce n'è una in serbo che dice: "Vi vinceremo con il cazzo". Il Kosovo è la regione europea con l'indice di natalità più alto. Più figli albanesi si fanno, meno serbi ci sono.
Cominciano i minareti, si cominciano a vedere i bar serbi e i bar albanesi; dove si mangiano le stesse schifezze, dove si serve lo stesso caffè polveroso. Però la birra è favolosa; ho sete ed entro in un bar. Serbo. Un bel nome: "Bife Velika Srbija". Bar Grande Serbia.
"Talijanac?" "Da, ja sam talijanac" "Talijanac? Roberto Baggio! Toto Skillazzi!". Il più basso è un metro e novanta. "Odakle ti si u Italiji?" "Od Livorna, u kolima Florencije, ale rodio sam u Otoku Elbe. Livorno je velika luka". Quel poco di serbo che parlo mi viene bene; Bevo la birra con un tizio che mi guarda da una cornice. "Prosim, ko je on?" "Na prezident, Slobodan Milosevic'". "Ah. Na zdravo vaa prezidenta"". Alla salute del vostro presidente. Manco mi fanno pagare; il 21 luglio 1990 ho bevuto alla salute di Slobodan Milosevic'. Zio Slobo m'ha fatto risparmiare i 780.000 dinari che costava la birra.
Contadini sui trattori. E soldati, soldati in marcia. Alcuni pure su dei trattori. Fuochi per la strada, di continuo; e cani morti. Non ho mai visto tanti cani morti, a disfarsi per la strada, con le budella nel sangue. S'entra a Titova Mitrovica, "Mitrovica e Titos", in albanese. Una baraccopoli di centoquindicimila abitanti. Un puzzo indefinibile per la strada, pozze di fango. E bambini. Ragazze giovanissime con bambini, due, tre, cinque. Bambini attaccati allo specchietto retrovisore, mentre vado a dieci all'ora per schivare le buche. Sigarette? Orologio? Biscotti? Un bambino mi chiede "orologio" in sei lingue. Un altro mi è montato sul cofano. Via tutti all'improvviso. È apparsa una specie di vecchia Fiat Seicento con scritto "Milicija", e mi si mette davanti fino alla fine della strada; poi mi ferma e mi chiede i documenti. Un poliziotto, alla fine, mi chiede che cazzo ci sono venuto a fare a Titova Mitrovica. "Ne znam", non lo so.
Ora tocca a "Radici", potenza della Locomotiva. Si mette a cantare anche lei, per un rettilineo che non finisce più, con un aria spaventosa e fuochi, fuochi accesi per la strada. Mi sta davanti una Saab con targa norvegese e il windsurf sul portabagagli; una bambina biondissima mi fa i salutini dal lunotto posteriore. "E contro ai re e ai tiranni scoppiava nella via la bomba proletaria" eccetera eccetera. Finestrini spalancati e pugno chiuso, proprio mentre si passava per Pristina. La bomba proletaria. Già. Illuminava l'aria. E, ogni tanto, un trattore. Una mucca. Una casa con il piano terra intonacato e il primo piano ancora a mattoni nudi.
Alle quattro del pomeriggio eran tornati quaranta gradi.
Dovrei dirvi che s'entrò in Macedonia, che a Skopje mangiammo tre panini con tonno e maionese in una piazza bevendo da una fontanella, che a Titov Veles (ora solo "Veles", Tito non esiste più, anzi, non è mai esistito) finii i dinari e mi feci mezz'ora di coda da un cambiavalute clandestino perché le banche erano chiuse, che gli avvocati lavorano nelle baracche (è pieno di capanne con su scritto "Advokat"; poi mi dissero che sono quelli che a Napoli si chiamano "avvocaticchi", che per due soldi difendono chiunque nelle cause da due soldi e mezzo). Dovrei dirvi, inoltre, che, con mossa veramente astuta, viaggiavo senza ruota di scorta e che, se foravo, erano volatili senza zucchero. Ma s'arrivò a Gevgelija, al confine con la Grecia, dove c'è pure il Casinò. In cirillico si legge qualcosa come "KACINO".
Eccole, le stellette della Comunità Europea. Eccoci nell'Ellade. Il Kasino alle spalle; quando ci sarei tornato, da quelle parti, non c'era più quella certa fanciulla, e volavano basse, diocristo se volavano basse. Come oggi. Come adesso. 1,50 del 25 marzo 1999.
Perchè tutti voi li avete presenti, quei nomi che sono andato dicendo. Podgorica: bombe. Mitrovica: bombe. Pritina: bombe. Bombe della NATO. Bombe serbe. Bombe albanesi. Cannoni. Soldati. Carri armati.
Autoblindo. Mortai. Missili. Spari. Urla. Sirene.
Da qualche parte starà vagando Il Caduto che ha visto quel poco di mondo attraverso un mirino.
Potrà forse consolare il fatto che da quelle parti non esistono funivie.
Si fa un talkin'?
Si fa un talkin'. Io ci sono. Antonio e Dodo Veroli no. L'americano è su un Tornado o su un F16 a sganciare le bombe intelligenti. Boy-Boy il cane è accanto a qualche fuoco, per la strada, con le budella all'aria; stecchito, a guardare con l'ultimo ghigno la gente sui trattori che scappa, scappa, scappa.
Riccardo Venturi, 25 marzo 1999.
Si fa un talkin'.
Partimmo una mattina verso Salonicco, io, la mia ragazza ed una Fiat Ritmo che reggeva l'anima coi denti, ma che era munita di un'autoradio. Vestiti leggeri, perché era il 21 luglio. Del 1990. Da Dubrovnik, che è una città bellissima. Da Dubrovnik che, l'anno dopo, sarebbe stata bombardata. Buchi nei tetti delle chiese. I palazzi dello "Stradun", i palazzi di pietra rosata in preda alle fiamme. I sacchetti di sabbia sotto la Fontana di Sant'Onofrio.
Era un periodo in cui la mia ragazza non amava troppo Guccini; ma da Dubrovnik a Salonicco ci sono novecentoundici chilometri di strade di merda. Prima di partire guardavo la cartina preoccupato; tutto il Montenegro, tutto il Kosovo, tutta la Macedonia e poi il confine con la Grecia, in un posto chiamato Gevgelija. Guai a chi m'avesse fatto traversare tutti i Balcani senza un po' di Guccini.
C'eravamo stati due anni prima, in Jugoslavia. In ogni posto, anche nei cessi, c'erano ritratti del Maresciallo Tito. Anche nei paesi più piccoli c'era una via che si chiamava "Ulica Bratstva i Jedinstva", via della Fratellanza e dell'Unità. Un po' come "via Roma" in Italia. Fratellanza e Unità. Già. Anche l'autostrada Zagabria-Belgrado si chiamava "Autoput Bratstva i Jedinstva". Ecco. Due anni dopo in Croazia c'erano ovunque le bandiere a scacchi bianchi e rossi. La signora Lijepe (vuol dire "Bella"), la nostra padrona di casa a Dubrovnik, si lamentava ogni mattina che era troppo "vruce", troppo caldo. Leggeva "Slobodna Dalmacija" bestemmiando contro i nazionalisti, diceva d'essere una vecchia comunista e una volta le ho rovesciato la vasca da bagno mettendomi a sedere sul bordo.
Un'ultima occhiata a Dubrovnik, dall'alto. Dopo dieci chilometri sei già a quasi mille metri d'altitudine. Il mare che scompare. Scompare l'Adriatico, scompaiono le delicatissime architetture veneziane, le "vere da pozzo", le lunghe scalinate fra gli oleandri. Di posti ne ho visti tanti, ma mai ho visto un confine tra due mondi in pochi chilometri d'una stradaccia.
S'arriva a Trebinje, che è in Erzegovina. Un'immensa caserma. Un'aria livida, strana, soffocante. Un soldato altissimo, biondissimo che vede una macchina con targa italiana, la ferma e mi chiede una sigaretta in inglese. Gli rispondo in serbocroato e si mette a ridere, perché è della Vojvodina, dove parlano quasi tutti ungherese. E allora gli do un pacchetto di Chesterfield, e lo saluto in ungherese.
"Viszontlatásra barátom". Arrivederci, amico. Mi guarda e se ne va; chissà che fine ha fatto. Da Trebinje hanno rovesciato tonnellate di bombe su Dubrovnik, come prendere qualcuno a sassate da un albero.
La mia ragazza non parla quasi mai. Guarda; si sale ancora, cominciano le abetaie. M'accorgo che sto per infilare la cassetta dove c'è "Canzone per un'amica", ma quella canzone, per strada, forse non è il caso di sentirla. Accendo la radio; un notiziario, musica strana, un caldo soffocante. Alla fine, vaffanculo. Quella non parla e guarda, non ci sono che alberi e l'aria si fa rossastra. Quando arrivo a Canzone per un'Amica, la salto. Anzi no, la sento. La strada era lunga, ma non correva affatto ed era piena di tornanti.
Gole. Gole profondissime. Non c'è un cazzo di nessuno. La mia ragazza, lo vedo, è leggermente terrorizzata; mi dice che sono un idiota, che son voluto passare di lì quando potevamo prendere una nave e ritrovarci a Patrasso. Aveva ragione. Le dico se vuole che torniamo indietro; ma si richiude nel suo mutismo. Ed allora vado avanti.
Avanti, avanti, fra le tombe dei Bogomili dell'Erzegovina, fra le tombe dei terribili bulgari che avevano seminato il terrore in mezz'Europa, mille anni prima. Fino a casa mia sono arrivati; il nome di Bòlgheri, il paese della poesia del Carducci, quello dei cipressi alti e schietti in duplice filàr, deriva da "bulgari". Glielo dico, ma non gliene frega niente. Merdre à toi, bogòmilo di merda. Lo dice Salvatore al cuciniere nel "Nome della Rosa". E si sale, si sale.
Comincia a fare meno caldo; poi fresco; poi decisamente freddo. C'è nebbia; lei s'è messa un asciugamano di spugna addosso, non avevamo altro e vattelappesca. Un vecchio gigantesco con una zappa sulla spalla, gli domando quanto manca a Titograd. Dva ciàsa. Ciàsa, ciàsa...già, qui parlano mezzo turco. Ciàsa vuol dire "ore" in turco. Due ore. Il vecchio scompare nella nebbia, in una stradina laterale.
E s'arriva a Titograd, città di Tito già dedicatagli in vita, come se Pàvana già adesso la chiamassero Guccinigrad (in treppiese, che, come disse un decerebrato qualche tempo fa, ha delle assonanze con il macedone). Ora ha ripreso il vecchio nome di Podgorica, che vuol dire "sotto i monti" e si pronuncia "podgòrizza". E ci credo. Monti e abeti, castagni e monti, monti e bambini per la strada. Carovane. La fanciulla ha un sussulto; "qui si muovono tutti". "Sembra che scappino", le rispondo. Già.
Altri monti, e una discesa a perdifiato. I cartelli stradali cominciano ad essere bilingui, in serbo e in albanese. "Eccoti la lingua dei tuoi avi", le faccio. Sono un monomaniaco; lingue e Guccini. La fanciulla fa Albanese, di cognome; siamo nel Kosovo. Nel Kosovo Polje, il "campo dei merli" dove, nel 1389, i serbi erano stati sconfitti dai turchi, dove esistono ancora dei vecchi "guslari" che ti cantano le antiche ballate per pochi spiccioli, una melanzana o un pezzetto di carne, dove vendono acqua e limone per la strada. Baracche e trattori; sul muro scritte, scritte e scritte. Quelle in albanese non le capisco; ma ce n'è una in serbo che dice: "Vi vinceremo con il cazzo". Il Kosovo è la regione europea con l'indice di natalità più alto. Più figli albanesi si fanno, meno serbi ci sono.
Cominciano i minareti, si cominciano a vedere i bar serbi e i bar albanesi; dove si mangiano le stesse schifezze, dove si serve lo stesso caffè polveroso. Però la birra è favolosa; ho sete ed entro in un bar. Serbo. Un bel nome: "Bife Velika Srbija". Bar Grande Serbia.
"Talijanac?" "Da, ja sam talijanac" "Talijanac? Roberto Baggio! Toto Skillazzi!". Il più basso è un metro e novanta. "Odakle ti si u Italiji?" "Od Livorna, u kolima Florencije, ale rodio sam u Otoku Elbe. Livorno je velika luka". Quel poco di serbo che parlo mi viene bene; Bevo la birra con un tizio che mi guarda da una cornice. "Prosim, ko je on?" "Na prezident, Slobodan Milosevic'". "Ah. Na zdravo vaa prezidenta"". Alla salute del vostro presidente. Manco mi fanno pagare; il 21 luglio 1990 ho bevuto alla salute di Slobodan Milosevic'. Zio Slobo m'ha fatto risparmiare i 780.000 dinari che costava la birra.
Contadini sui trattori. E soldati, soldati in marcia. Alcuni pure su dei trattori. Fuochi per la strada, di continuo; e cani morti. Non ho mai visto tanti cani morti, a disfarsi per la strada, con le budella nel sangue. S'entra a Titova Mitrovica, "Mitrovica e Titos", in albanese. Una baraccopoli di centoquindicimila abitanti. Un puzzo indefinibile per la strada, pozze di fango. E bambini. Ragazze giovanissime con bambini, due, tre, cinque. Bambini attaccati allo specchietto retrovisore, mentre vado a dieci all'ora per schivare le buche. Sigarette? Orologio? Biscotti? Un bambino mi chiede "orologio" in sei lingue. Un altro mi è montato sul cofano. Via tutti all'improvviso. È apparsa una specie di vecchia Fiat Seicento con scritto "Milicija", e mi si mette davanti fino alla fine della strada; poi mi ferma e mi chiede i documenti. Un poliziotto, alla fine, mi chiede che cazzo ci sono venuto a fare a Titova Mitrovica. "Ne znam", non lo so.
Ora tocca a "Radici", potenza della Locomotiva. Si mette a cantare anche lei, per un rettilineo che non finisce più, con un aria spaventosa e fuochi, fuochi accesi per la strada. Mi sta davanti una Saab con targa norvegese e il windsurf sul portabagagli; una bambina biondissima mi fa i salutini dal lunotto posteriore. "E contro ai re e ai tiranni scoppiava nella via la bomba proletaria" eccetera eccetera. Finestrini spalancati e pugno chiuso, proprio mentre si passava per Pristina. La bomba proletaria. Già. Illuminava l'aria. E, ogni tanto, un trattore. Una mucca. Una casa con il piano terra intonacato e il primo piano ancora a mattoni nudi.
Alle quattro del pomeriggio eran tornati quaranta gradi.
Dovrei dirvi che s'entrò in Macedonia, che a Skopje mangiammo tre panini con tonno e maionese in una piazza bevendo da una fontanella, che a Titov Veles (ora solo "Veles", Tito non esiste più, anzi, non è mai esistito) finii i dinari e mi feci mezz'ora di coda da un cambiavalute clandestino perché le banche erano chiuse, che gli avvocati lavorano nelle baracche (è pieno di capanne con su scritto "Advokat"; poi mi dissero che sono quelli che a Napoli si chiamano "avvocaticchi", che per due soldi difendono chiunque nelle cause da due soldi e mezzo). Dovrei dirvi, inoltre, che, con mossa veramente astuta, viaggiavo senza ruota di scorta e che, se foravo, erano volatili senza zucchero. Ma s'arrivò a Gevgelija, al confine con la Grecia, dove c'è pure il Casinò. In cirillico si legge qualcosa come "KACINO".
Eccole, le stellette della Comunità Europea. Eccoci nell'Ellade. Il Kasino alle spalle; quando ci sarei tornato, da quelle parti, non c'era più quella certa fanciulla, e volavano basse, diocristo se volavano basse. Come oggi. Come adesso. 1,50 del 25 marzo 1999.
Perchè tutti voi li avete presenti, quei nomi che sono andato dicendo. Podgorica: bombe. Mitrovica: bombe. Pritina: bombe. Bombe della NATO. Bombe serbe. Bombe albanesi. Cannoni. Soldati. Carri armati.
Autoblindo. Mortai. Missili. Spari. Urla. Sirene.
Da qualche parte starà vagando Il Caduto che ha visto quel poco di mondo attraverso un mirino.
Potrà forse consolare il fatto che da quelle parti non esistono funivie.
Si fa un talkin'?
Si fa un talkin'. Io ci sono. Antonio e Dodo Veroli no. L'americano è su un Tornado o su un F16 a sganciare le bombe intelligenti. Boy-Boy il cane è accanto a qualche fuoco, per la strada, con le budella all'aria; stecchito, a guardare con l'ultimo ghigno la gente sui trattori che scappa, scappa, scappa.
Riccardo Venturi, 25 marzo 1999.
×
![]()